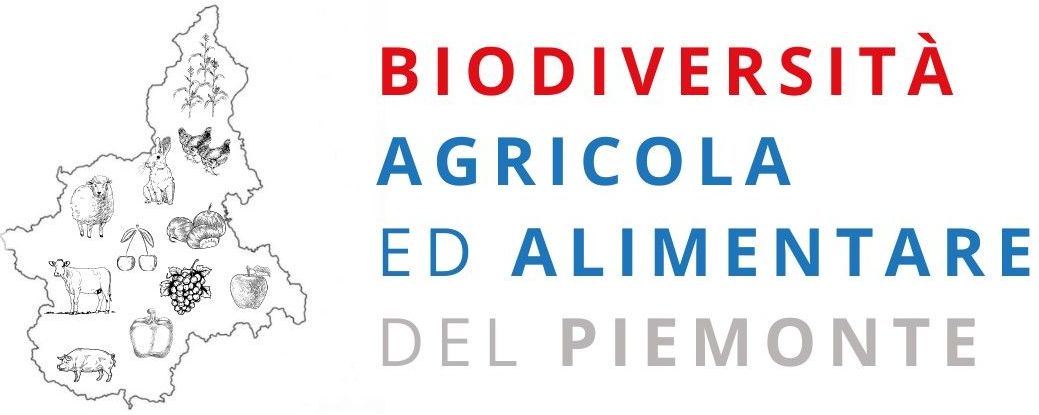Attività
Conservazione ex-situ
Le banche del germoplasma.
Grugliasco (TO)
DISAFA
La banca del germoplasma
La Banca del Germoplasma del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA, settore Genetica Vegetale, Università degli Studi di Torino) è stata istituita nel 1981 con l’obiettivo di conservare, sotto forma di semi, vecchi ecotipi locali e cultivar piemontesi di specie di interesse agrario ed in particolare di specie ortive, un tempo largamente coltivati ma soggetti nel tempo ad progressivo abbandono e, pertanto, a rischio di estinzione.
Le specie su cui inizialmente si è incentrata maggiormente l’attenzione sono state peperone e fagiolo da granella; tale scelta è stata motivata dall’ampia diffusione e dalla notevole importanza che tali colture hanno in Piemonte. Più recentemente, la Regione Piemonte (settore Sviluppo Agricolo), ha finanziato attività di ricerca finalizzate all’analisi e caratterizzazione di 10 ecotipi di specie ortive e sette ecotipi di mais al fine di procedere con la loro iscrizione al Registro Nazionale come “varietà da conservazione”.
La caratterizzazione degli ecotipi piemontesi conservati entro la Banca del Germoplasma non si è basata unicamente sulla rilevazione di caratteristiche morfologiche e produttive, che possono peraltro essere influenzate dall’ambiente di coltivazione, ma anche sull’applicazione di tecniche di analisi del DNA (marcatori molecolari) che consentono di quantificare con maggior accuratezza ed affidabilità la variabilità genetica presente nel materiale conservato e l’effettiva differenziazione genetica tra i diversi ecotipi . Ciò ha consentito di mantenere in conservazione materiali rappresentativi sia dell’ideotipo di ciascuna delle varietà da conservazione che della variabilità genetica presente in coltivazione.
Le modalità di conservazione prevedono che il materiale in ingresso subisca una deidratazione in ambiente controllato (15°C, 15% UR) affinché il contenuto di acqua all’interno dei tessuti ne permetta la conservazione per lunghi periodi a -20°all’interno di speciali contenitori in plastica o alluminio termosaldato. Quando le quantità di seme sono sufficienti, una porzione del lotto conservato non viene stoccato a lungo termine ma viene impiegato per la creazione di “collezioni attive”. Le collezioni attive sono lotti di semente mantenute a temperature più elevate (-5°C) rispetto a quelle destinate alla conservazione per lungo periodo e destinate a soggetti pubblici o privati che ne fanno richiesta.
L’utilità pratica dell’attività di conservazione del germoplasma ovviamente può essere stimata solo nel lungo periodo, come peraltro lunghi tempi sono spesso necessari per l’applicazione di programmi di miglioramento genetico e selezione di nuove varietà.
Chiusa Pesio (CN)
Centro regionale di castanicoltura
Il Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte è sorto nel 2003 per iniziativa di Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino e Comunità Montane locali, è stato istituito con L.R. 4 del 10/2/2009 ed aggrega oggi Enti e soggetti privati interessati alla castanicoltura. Le attività sono coordinate dal DISAFA dell’Università di Torino.
Oltre a condurre progetti di ricerca, fornire servizi di consulenza, analisi, divulgazione e formazione, il Centro mantiene il Castanetum che rappresenta attualmente la più vasta collezione ex situ del genere Castanea a livello internazionale. Sono presenti infatti oltre 120 cultivar, con profilo genetico definito e inserito in uno specifico database, provenienti da tutto il territorio regionale e da gran parte di quello nazionale, oltre a specie e accessioni provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei.
Il Centro è riconosciuto a livello nazionale come:
- Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale, con riferimento al castagno (DM congiunto Ministero Transizione Ecologica e MIPAAF – G.U.n.141);
- Centro per la conservazione per la premoltiplicazione di materiali di moltiplicazione del castagno; centro di riferimento per la filiera vivaistica italiana del castagno (DM del MIPAAF - GU Ser.Gen. n.22 del 28-01-2021);
- Centro MIPAAF DUS per le prove di coltivazione di varietà di castagno da frutto ai fini dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Piante da Frutto, al rilascio di titoli di protezione per nuove varietà vegetali e per l’esecuzione delle prove di coltivazione finalizzate all’accertamento dei requisiti di Distinguibilità, Uniformità e Stabilità del castagno (ai sensi dell’art.8, c.1, del DM 6/12/2016).
Tali riconoscimenti avvalorano le attività condotte negli anni dal Centro Regionale di Castanicoltura a tutela della biodiversità sia a fini naturalistici ed ambientali, sia a fini di sviluppo della coltura in contesto agricolo.
Grinzane Cavour (CN)
Collezione di viti
Situato nei terreni un tempo di proprietà dei Benso di Cavour, il vigneto di collezione raccoglie oggi più di 500 varietà di vite, in buona parte vitigni minori e rari, spesso in via di abbandono se non ormai scomparsi dai vigneti commerciali. Vi sono ospitate le varietà di vite dell’Italia nord-occidentale (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), oltre a cultivar nazionali e internazionali di riferimento. Con le sue oltre 800 accessioni coltivate su di 1.5 ha di superficie, la collezione di Grinzane mantiene vivo ed attivo un patrimonio di inestimabile valore biologico, storico e scientifico. È in sostanza un museo a cielo aperto delle risorse genetiche attuali e di un tempo.
La collezione nasce nel 1992 per conservare vitigni in via di abbandono recuperati negli anni dal CNR, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, con proprie risorse e grazie alle segnalazioni di viticoltori, vivaisti, appassionati.
Nel 2012-2013 è stato realizzato un nuovo impianto con il materiale già collezionato e con nuove introduzioni, dismettendo gradualmente il vecchio vigneto. Per la quasi totalità delle accessioni l’identità varietale è stata verificata con metodi morfologici e/o genetici.
Oltre a servire alla conservazione di risorse genetiche spesso uniche ormai introvabili altrove, la collezione serve alla didattica, alla sperimentazione agronomica e a studi di genetica, genomica, patologia, tecnologia enologica e di tutte quelle discipline legate alla vite che si avvantaggiano di un’ampia base di diversità genetica.
Supporto tecnico e cure colturali: Vignaioli Piemontesi e Istituto Umberto I di Alba. Contributi: dal 1992 al 2013 e nel biennio 2018-2019: Regione Piemonte. 2020-2021: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Dal 2020: Consorzio Albeisa.
Chieri (TO)
Tetti Grondana
Centro di frutticoltura
Il Centro di Frutticoltura Tetti Grondana si trova a Chieri ed è distribuito su 12 ettari. Ospita una vasta collezione di fruttiferi, sia autoctoni sia di provenienza nazionale ed internazionale, che include entità rare o in via di estinzione.
Attualmente sono presenti nel centro circa 800 accessioni (254 cultivar di melo, 110 di pesco, 120 di ciliegio, 38 di pero, 30 di albicocco, 60 di susino, 60 di mandorlo, 33 di noce, 90 di nocciolo) di cui circa il 50% è costituito da materiale autoctono piemontese.
I frutti delle collezioni vengono utilizzati come campioni in mostre pomologiche allestite in occasione di convegni ed incontri a livello nazionale.
Sono presenti anche collezioni di vitigni (di cui 30 da vino e oltre 30 da tavola), di gelso e di altri fruttiferi minori, ed una vigna di Freisa Doc (2000 metri quadrati).
Il Centro ospita numerose attività di ricerca che riguardano principalmente la conservazione, la descrizione del germoplasma locale e il mantenimento delle collezioni di fruttiferi per evitare l’erosione genetica e la conseguente perdita di biodiversità.
A titolo di esempio possiamo citare il progetto PROPRUNUS, realizzato con il contributo della Regione Piemonte (finanziato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 10 - Operazione 10.2.1) con lo scopo specifico di rinnovare e ampliare le collezioni di germoplasma locale delle drupacee piemontesi (pesco, ciliegio, susino e mandorlo) realizzate a partire dal 1980.
Oltre alle attività di ricerca, nel Centro si svolgono numerose attività didattiche che vedono coinvolti studenti della laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie, studenti della laurea magistrale in Scienze Agrarie e Scienze e Tecnologie dei Sistemi e Territori Forestali.
Il Centro di frutticoltura è poi attivamente impegnato in attività di formazione con scuole e associazioni del territorio.
Pollenzo (CN)
UNISG
Collezione di cereali autunno vernini
La Casa della Biodiversità Piemontese, ospitata presso l’Orto Educativo dell'Università di Scienze Gastronomiche, conserva lotti di seme di circa 60 varietà di frumento tenero, segale e farro. Le varietà conservate sono state oggetto di studio e ricerca a partire dal 2010 (progetto “Frulogico”, finanziato dalla Regione Piemonte e realizzato da CRAB-Centro Riferimento Agricoltura Biologica e UNISG) fino ad oggi (progetti Germonte).
I progetti di ricerca hanno permesso la caratterizzazione agronomica e morfologica di alcune varietà e l’inserimento all’interno dell’”Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” di 11 varietà di frumento tenero.
Ogni anno sono allestiti campi sperimentali a parcelle con alcune delle varietà conservate, con l’obiettivo di proseguire le attività di ricerca e la moltiplicazione del seme delle varietà ritenute più interessanti.
Le parcelle sono raccolte, mietute e trebbiate a mano, selezionata la granella e pulita. Il seme raccolto viene selezionato, catalogato e mantenuto in sacchetti in polietilene. La conservazione viene effettuata alla temperatura di – 18°C
Alcune delle varietà e miscele conservate all’interno della collezione UNISG-AIAB in Piemonte:
- T. aestivum: Gentilrosso, Frassineto, Solina, Rieti 11, Rosso Langhe, Est Mottin, Risciola, Precoce Piemonte, Verna, Andriolo, Noè, Sieve, Villa Glori, Tosella, Irnerio, Cologna Lunga, Autonomia A, Autonomia B, Jacometti, Virgilio, Caruso Girolamo, Vittorio Niccoli, Lontra, Rosso Piemonte, Marzotto, Bianco di Suvero, Fiorello, Ardito, Inallettabile, miscela Solibam, Miscela Piemonte;
- T. monococco: farro monococco nero;
- T. dicoccum;
- S. cereale: segale di Teglio.
Bibiana (TO)
Fondazione Malva Arnaldi
Collezione di pomacee
Il campo collezione della Fondazione Malva Arnaldi nasce a Bibiana (TO) nel 1997 con il finanziamento di un progetto Interreg a regia pubblica (Programma INTERREG II) denominato “Salvaguardia e valorizzazione del germoplasma piemontese di melo e pero”
Il progetto ha visto la realizzazione di un unico campo collezione, ad opera della Scuola Malva di Bibiana, in collaborazione con il Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli Studi di Torino, con le accessioni fino ad allora presenti in numerosi campi minori dislocati sul territorio regionale, individuando nella Scuola Malva uno dei punti di riferimento regionali per la conservazione e la valorizzazione delle biodiversità.
Complessivamente sono state messe a dimora nel biennio 1998-99 oltre 400 varietà di melo, e 80 di pero. Furono impiantati 3 esemplari per ogni varietà e al fine di rendere comparabili i dati raccolti venne impiegato il medesimo portainnesto per tutte le varietà.
Negli anni successivi è stato costituito un centro di documentazione con materiale bibliografico e schede relative alle prime descrizioni degli alberi e dei frutti. A partire dal 2000, con l’entrata in produzione della collezione, è iniziata l’attività di caratterizzazione delle varietà in conservazione.
L’attività di caratterizzazione e valorizzazione è proseguita negli anni seguenti tramite finanziamenti della Regione Piemonte (Bandi per linee, Attività negoziata), PSR Mis. 10.2.1, programmi Alcotra, iniziative della Camera di Commercio della Provincia di Torino.
La presenza della collezione ha contribuito alla nascita dell’Associazione dei produttori Antiche Mele Piemontesi che, anche grazie al Presidio Slow Food delle Vecchie Mele Piemontesi, continua le attività di promozione e valorizzazione delle biodiversità pomicole; i coltivatori aderenti sono una quindicina concentrati soprattutto in Val Pellice, pianura cavourese e alcune aziende con sede nel saluzzese.
Vercelli
CREA CI
Collezione di riso
La Sede di Vercelli del CREA, Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI), nasce nel 1908 come Stazione Sperimentale di Risicoltura e delle Coltivazioni Irrigue. Attualmente si occupa prevalentemente di genetica e genomica applicata al miglioramento genetico del riso e del frumento tenero.
Presso la propria banca del germoplasma conserva un’ampia collezione, costituita da oltre 4000 accessioni di frumento tenero, comprendente vecchie e nuove varietà, italiane ed internazionali e popolazioni storiche di frumenti locali italiani, e 700 di riso. La collezione è mantenuta, caratterizzata e valorizzata grazie al finanziamento di progetti internazionali (es. AGENT,
https://www.agent-project.eu) e nazionali (es. RGV-FAO, finanziato dal Masaf, TRANSFER, finanziato da Regione Lombardia, FSMT, finanziato dalla Regione Liguria).